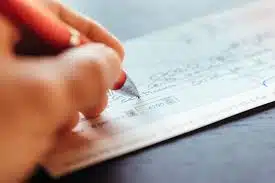La caparra confirmatoria, disciplinata dall’art. 1385 c.c. prevede che
“se al momento della conclusione del contratto, una parte dà all’altra – a titolo di caparra – una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra – in caso di adempimento – deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è, invece, la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
In poche parole, possiamo senza dubbio affermare che la caparra confirmatoria esercita, da un lato, la funzione di cautela per il risarcimento dei danni in caso di inadempimento, dall’altro assolve a una triplice funzione: assertiva o confirmatoria, di acconto e di indennizzo.
La sua prima funzione è, pertanto, quella di dimostrare l’esistenza del contratto in sé. La caparra, difatti, fa presumere che esista un accordo di natura contrattuale al quale è inevitabilmente collegata.
La seconda funzione, ovvero quella di acconto, consiste nel versamento di un anticipo della prestazione dovuta da parte di una delle parti contraenti.
La terza e ultima funzione è quella di predeterminare l’ammontare dei danni, ovvero di rafforzare il diritto del creditore al risarcimento stabilendo e specificando preventivamente l’ammontare del danno ad effetto dell’inadempimento dell’obbligazione principale.